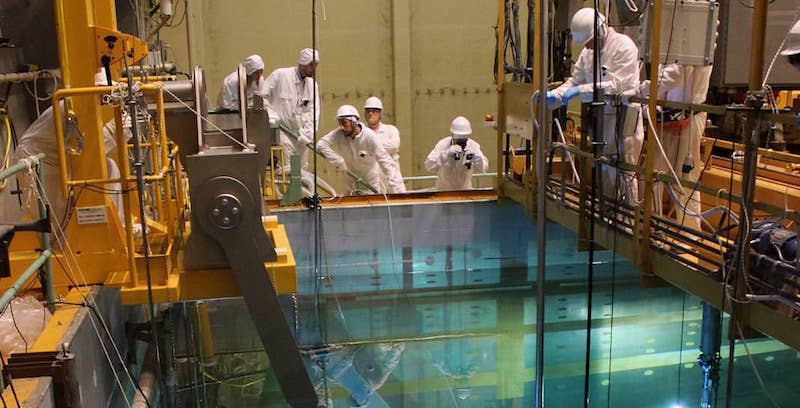Quando l’arte tace: il silenzio che fa rumore
di Lina Angela Barbieri
Un concerto sinfonico non si farà. Un grande direttore d’orchestra non salirà sul podio. Il cortile monumentale che avrebbe dovuto ospitare una delle alte espressioni della musica resterà in silenzio. E quel silenzio, oggi, pesa più di qualsiasi nota mancata.
La cancellazione dell’esibizione di un artista – per quanto illustre – in ragione della sua identità o delle sue posizioni è un gesto che va ben oltre la cronaca. È un atto che ci interroga. Dove finisce il diritto alla bellezza? Quando l’arte cessa di essere rifugio e diventa bersaglio?
In tempi di conflitti, l’istinto è spesso quello di tracciare linee nette: giusto o sbagliato, amico o nemico. Ma l’arte non conosce fronti. Non parla la lingua dei governi. Non giura fedeltà a nessun vessillo. L’arte, quando è autentica, si eleva sopra il dissidio e sfida la logica binaria della guerra. È, da sempre, il territorio neutrale dell’umano.
Rinunciare a un concerto perché l’artista proviene da un contesto problematico o per le sue affiliazioni politiche può sembrare una scelta etica. Ma rischia di diventare una rinuncia al potere stesso della cultura come ponte. Come dialogo. Come provocazione nobile.
La musica – forse più di ogni altra forma espressiva – ha la forza di unire ciò che l’uomo divide. In essa convivono lingue, tradizioni, identità che altrimenti non si parlerebbero mai. Escludere un musicista per ciò che rappresenta fuori dalla musica significa ridurre l’arte a un atto ideologico. E questo significa amputarne la sua potenza più elevata: quella di trasformare, attraversare, disarmare.
C’è chi sostiene che esibire un artista controverso significhi legittimarlo. Ma forse è vero il contrario: accoglierlo in nome della musica è ricordare a tutti – lui per primo – che esiste un linguaggio che precede e supera ogni conflitto. Che la bellezza, proprio perché inutile, è essenziale. Che si può dialogare anche in silenzio, semplicemente ascoltando.
La pace non nasce mai dall’eliminazione del dissenso. Nasce dalla fatica del confronto, dalla convivenza delle contraddizioni, dalla scelta di non chiudere le porte. L’arte, in questo, è alleata preziosa. È una possibilità di tregua, uno spiraglio di umanità nel buio delle appartenenze.
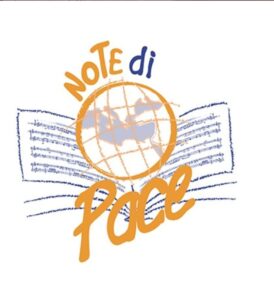
Quando la guerra chiude ogni dialogo, la cultura diventa un atto di resistenza, non contro qualcuno, ma contro l’imbarimento. Far suonare un’orchestra, leggere ad alta voce una poesia: tutto questo per affermare che, nonostante tutto, siamo ancora vivi.
Ma c’è di più. L’arte non consola soltanto. Interroga. Non accarezza soltanto. Scuote. La sua bellezza non è sempre facile. Spesso è scomoda, dolorosa, tagliente. E proprio per questo ci aiuta ad andare oltre noi stessi. Ci educa all’empatia, alla complessità, alla tensione interiore che è il seme della pace.
Naturalmente l’arte non è innocente. Nessuna creazione è neutra.
Ma all’artista si chiede il coraggio di non omologarsi, di non vendersi. Ma anche al pubblico si chiede qualcosa: la pazienza dell’ascolto, il rispetto del dubbio.
La forza di restare davanti a ciò che non si capisce subito.
La pace, del resto, non è mai un bene comodo: è un esercizio continuo, una disciplina dell’anima.
In ogni tempo buio c’è stato qualcuno che ha custodito una scintilla. Sono questi i fuochi che non vanno spenti.
Forse quel concerto non avrebbe cambiato il mondo. Ma sappiamo con certezza cosa ci è stato tolto: un’occasione per affermare che la cultura non è complice ma custode; non arma ma rifugio; non propaganda ma preghiera.
E quando neghiamo alla musica il diritto di farsi sentire, non puniamo solo un direttore d’orchestra. Ci priviamo tutti dell’opportunità di essere migliori, anche solo per una sera.