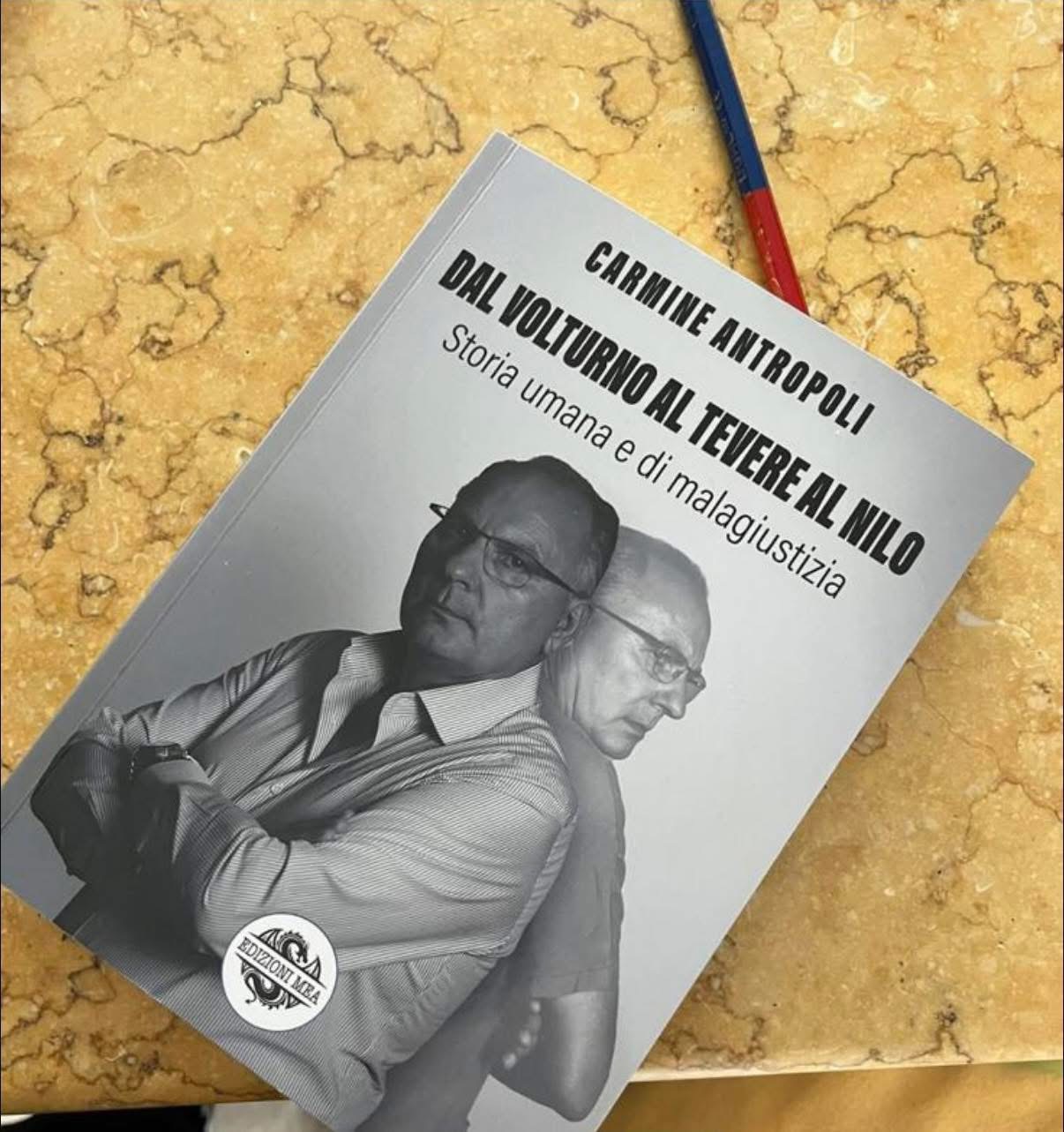Di Angela Barbieri
28 luglio 2025 – A Venezia, un gioielliere ha recentemente lanciato una provocazione: far pagare 100 euro per l’ingresso in città. Una proposta paradossale, che tuttavia riaccende il dibattito su quale sia oggi il rapporto fra turista e territorio, fra diritto alla bellezza e logica del profitto, fra il consumo di un’esperienza e il suo prezzo.
Non è un caso isolato: sempre più spesso, da Nord a Sud, si levano le voci di ristoratori, albergatori, negozianti che lamentano la “parsimonia” dei turisti. “Dividono un piatto di pasta in due”, “non comprano gioielli”, “consumano poco”. La diagnosi, per alcuni, è chiara: un turismo che c’è, ma che non “spende abbastanza”.
Ma basta cambiare prospettiva – quella del viaggiatore – e si apre un altro scenario: prezzi gonfiati, listini che sembrano studiati per scoraggiare i portafogli più onesti, porzioni ridotte e scontrini che sembrano insulti. Camminare a Venezia, Roma, Firenze, Napoli, non è più solo un’esperienza artistica o spirituale: è un’impresa economica. Tra tasse di soggiorno, biglietti d’ingresso ai monumenti e menu-trappola, il turista è spesso trattato non come un ospite da accogliere, ma come una risorsa da spremere.
Il paradosso dell’accoglienza
Che cosa c’è dietro questo disallineamento profondo? Forse un errore di fondo: l’idea che il turismo sia una miniera da cui estrarre ricchezza immediata, anziché un’occasione di incontro, scambio e crescita condivisa. Si dimentica che non esiste consumo della bellezza se non attraverso la partecipazione, la curiosità, il rispetto. Ma tutto ciò si costruisce solo se chi arriva non si sente un bancomat ambulante.
Quando i commercianti si indignano perché i turisti non comprano anelli da 500 euro o dividono un primo piatto da 24 euro, forse dovrebbero interrogarsi su quanto i loro prezzi siano accessibili, onesti, proporzionati. Non è più tempo per una Venezia da cartolina e da boutique di lusso: il mondo è cambiato, e il turismo mordi-e-fuggi, se non è governato con intelligenza e giustizia, rischia di trasformare i centri storici in trappole dorate per pochi privilegiati.
C’è poi un tema ancora più grave, e forse più scomodo: quello della diseguaglianza culturale. Quando una città impone tariffe d’ingresso, aumenta indiscriminatamente i prezzi o costruisce ostacoli economici all’accesso ai suoi beni, sta esercitando una forma moderna e subdola di razzismo sociale. Sta dicendo, implicitamente: “Questa bellezza non è per tutti”. È un messaggio velenoso, perché mina alla radice uno dei principi fondanti della civiltà: che il patrimonio artistico, storico e paesaggistico appartiene a tutti, e tutti hanno il diritto di goderne.
Chi decide quali occhi possono contemplare il Canal Grande, chi può permettersi un caffè in Piazza San Marco, chi ha il diritto di entrare in un museo senza essere economicamente respinto? È inaccettabile che l’arte, la cultura, la memoria diventino il privilegio di pochi, mentre i molti restano fuori, esclusi non per scelta, ma per condizione.
Il diritto alla bellezza
L’articolo 9 della Costituzione italiana parla chiaro: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Non dice “per chi può permetterselo”. Dice per tutti. Eppure, l’accesso alla bellezza è oggi sempre più filtrato da barriere economiche. In questo, Venezia è solo un caso emblematico. Ma potremmo parlare anche di musei con biglietti esorbitanti, di chiese divenute a pagamento, di borghi ormai snaturati da logiche alberghiere che spazzano via gli abitanti e creano scenografie per turisti-spettatori.
Serve una nuova cultura dell’accoglienza
La vera sfida, allora, è rovesciare la logica. Non chiedersi quanto può fruttare ogni turista, ma che tipo di esperienza può vivere. Non puntare al consumo, ma alla condivisione. Il turista rispettoso – anche se divide un piatto – non è un problema, ma un alleato. È la cultura dell’accoglienza che va rigenerata, a partire dai suoi presupposti: equità, accessibilità, responsabilità reciproca.
Tassare i visitatori per scoraggiarli, come proposto provocatoriamente dal gioielliere veneziano, è l’anticamera della chiusura culturale. È la negazione dell’idea di Europa aperta, solidale, capace di mettere in circolo la bellezza come bene comune.
Serve un pensiero nuovo, che tenga insieme economia e giustizia, turismo e diritto. E che non dimentichi mai che la bellezza – quella vera – è tale solo se è di tutti.